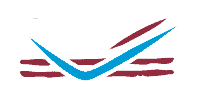Giordania – Diario di Viaggio – Settimo giorno
GIORDANIA – DIARIO DI VIAGGIO
7 gennaio 2023
I campi informali di Mafraq
Nel corso di una difficile video call improvvisata sul pullman, con la connessione che va e che viene, Massimo, responsabile di Vento di Terra per la Giordania, tenta di spiegarci brevemente la storia dei campi informali giordani. Nel corso degli anni, dall’inizio della guerra civile in Siria, nel 2011, la Giordania ha accolto un numero enorme di profughi, che inizialmente hanno trovato rifugio nei campi di accoglienza ufficiali sotto l’egida della UNHCR, l’agenzia ONU che si occupa dei rifugiati a livello globale. Col tempo però, questi campi “ufficiali” si sono trasformati in vere e proprie prigioni dorate, dalle quali non è possibile uscire se non con un permesso lavorativo. La vita quotidiana inoltre è regolata da norme che si sono fatte sempre più rigide e severe. Molti profughi allora hanno scelto un’alternativa rischiosa: fuggire dai campi ufficiali e stabilirsi in mezzo al nulla, in campi improvvisati detti appunto “informali” perché non riconosciuti dalla legge giordana né da quella internazionale. Il governatorato di Mafraq, nei pressi del confine settentrionale che divide il Paese dalla Siria, è una delle zone in cui questi assembramenti sono più numerosi.
Ci arriviamo dopo aver seguito lungo un percorso tortuoso un pick-up che ci aspettava al crocevia di una strada in mezzo al nulla: pochi campi coltivati e poi solo deserto a perdita d’occhio. Quando scendo dal pullman, penso di essere nel posto sbagliato. Non c’è nulla, a parte poche baracche in muratura sparse qua e là. Un gruppo di bambini di età diverse ci viene subito incontro, indossano tute da ginnastica e scarpe di gomma lacere, solo pochi fortunati hanno le scarpe da tennis. Non ero mai stata in un campo profughi e pensavo che i racconti di amici e conoscenti fossero solo un luogo comune. Invece, la prima cosa che mi colpisce davvero è il loro sorriso: aperto, vivo, contagioso. Anche se siamo in mezzo al nulla e il nulla è la loro esperienza quotidiana. Subito ci mettiamo in cerchio in mezzo al grande spiazzo fangoso davanti alle baracche, e con l’aiuto della guida locale improvvisiamo un girotondo e altri semplici giochi che perfino i bambini di qui conoscono: bandiera, ce l’hai, un due tre stella! Il linguaggio dei gesti è senza confini e ci aiuta a comunicare con loro. Vederli uno accanto all’altro, con le tute colorate e lo sguardo che da diffidente si fa sempre più aperto e diretto, è qualcosa che tocca l’anima. Ma anche noi adulti siamo commossi, stare qui è un’esperienza inaspettata e intensa, che fa risuonare corde troppo spesso dimenticate. Ci facciamo travolgere dal gioco, con la voglia di farli e di farci felici, di scordare per un attimo la nostra realtà entrando in una dimensione sospesa. Ciascuno di noi trova qualcuno con cui scambiare gesti, informazioni, sorrisi. Io e Marilena ci
avviciniamo a due ragazzine di 12 e 13 anni, i nomi purtroppo non li ricordo. La prima indossa una tuta gialla, ha i capelli neri raccolti in una coda di cavallo e due occhi vivaci e furbissimi. È l’unica delle due a conoscere qualche parola di inglese, e ogni tanto si rivolge spazientita alla sua amica che fatica a farsi capire. Sono entrambe siriane, la prima ha nove fratelli, il padre è morto e questo spiega il suo atteggiamento furbo e sveglio, di chi per sopravvivere deve lottare ogni giorno. La seconda ha una sorella, è più tranquilla ma ugualmente determinata. Marilena chiede loro cosa vogliono fare da grandi: “L’insegnante” risponde subito la prima. La seconda cerca di spiegarsi ripetendo ossessivamente una parola, “motofe”, o qualcosa del genere, come se ripetendolo più volte noi potessimo capirne il significato. Dopo molti tentativi falliti – “motofe”, dai, è così chiaro!, sembra dire la ragazzina battendo un pugno sull’altro con forza – Marilena si procura un pezzetto di carta e una penna, sul quale lei scrive, manco a dirlo, “motofe”… Scoppiamo a ridere, ormai è diventata una sfida e un po’ esasperate andiamo in cerca del responsabile del campo, che finalmente ci svela l’arcano: “motofe” vuol dire giudice, avvocato, e il movimento del pugno sopra l’altro stava a indicare quello del magistrato che batte sul banco con il martelletto.
Una delle due sorride quando le regalo un pallone, rosa come la sua tuta. Lo prende come a dire “è solo mio” e stringendolo al petto lo porta in un luogo sicuro. L’altra ci guarda e sorride, dice che siamo “cute” e noi rispondiamo che anche lei lo è. Si illumina toccando gli orecchini di Marilena.
La nostra “conversazione” dura circa un’oretta, e viene interrotta solo perché nel campo è ora di pranzo. Prima però seguiamo Marisa, che insegna educazione fisica, all’interno di una delle baracche, dove alcune donne sono riunite in cerchio per assistere a una lezione di primo soccorso. Ci sono anche dei neonati, avvolti in un fagotto di coperte pesanti e posati su un materasso in un angolo, oppure in grembo alle madri. Nonostante le circostanze, ho la sensazione che siano al caldo e al sicuro, accuditi nel modo migliore e più naturale. Le donne ascoltano Marisa con grande curiosità, soprattutto quando Giulia si presta a fare il “morto” nella dimostrazione su come rianimare una persona in difficoltà. Ce n’è una in particolare che sgrana gli occhi e annuisce a ogni parola, con una “fame” di conoscenza e una curiosità che mi colpiscono molto. È una situazione incredibile trovarsi in mezzo al nulla, a contatto con gente così diversa e in una realtà lontana anni luce da quella a cui sono abituata. Eppure, provo un senso di pace e di benessere, la sensazione di essere al posto giusto nel momento giusto, perfettamente centrata e a mio agio.
Prima di salutarci, il responsabile del campo ci racconta qualche dettaglio di vita quotidiana. La corrente prima non c’era, adesso è assicurata da un unico cavo al quale è possibile attaccarsi per gli utilizzi fondamentali. Le condizioni igieniche sono pessime, e di conseguenza malattie e infezioni sono molto frequenti. I bambini del campo – non tutti però – vanno a scuola ma solo nel pomeriggio, perché la mattina è riservata ai coetanei giordani. Non essendo campi riconosciuti dal governo, nessuno di loro possiede documenti né è autorizzato a ricorrere all’assistenza sanitaria. Sopravvivono grazie alle coltivazioni e all’aiuto di qualche ONG come Vento di Terra, ma il loro futuro è incerto e non si intravedono soluzioni a portata di mano. Il rischio è che diventino dei “profughi permanenti”, senza patria e senza prospettive, travolti da una Storia che è molto più grande di loro. Bisogna parlarne, mantenere i riflettori accesi, e non dimenticare. Mai.
Il sole sta tramontando mentre percorriamo un tratto del deserto orientale, che si estende per centinaia di chilometri a est di Amman, superando i confini giordani fino toccare Baghdad. Oggi rappresenta una delle aree meno accoglienti e popolate del paese, ma durante il periodo della dinastia Omayyade (VII secolo) era una zona di terreni fertili, molto ambita dai califfi di Damasco in cerca di un po’ di sollievo dal caos e dalle fatiche della vita cittadina. Per questo vi costruirono palazzine di caccia, caravanserragli e fattorie, in seguito definiti “castelli del deserto”, tra gli edifici più antichi e affascinanti di tutta la Giordania. Ci fermiamo davanti a una di queste costruzioni, il castello di Qusayr Amra, famoso per i suoi affreschi “audaci” e per alcune scene che la religione musulmana, con la proibizione di raffigurare in pittura o scultura qualunque essere vivente, riterrebbe senz’altro immorali. Nel piccolo ambiente interno, i nostri occhi faticano ad abituarsi all’oscurità ma a poco a poco intravediamo la figura di una donna nuda che fa il bagno, e poi ancora musici, danzatrici senza veli, cherubini, cesti di frutta e animali di una bellezza inaspettata. Sembra che i califfi considerassero il castello come una sorta di zona franca, un luogo dove le rigide regole della loro religione potevano essere dimenticate o comunque allentate almeno per un po’.
Quando usciamo, il sole sta per toccare la linea dell’orizzonte e una luce sovrannaturale inonda il piccolo castello e il grande deserto che lo circonda. È questa l’ultima immagine della Giordania che mi porto nel cuore: domani si torna in Italia, diversi da come siamo partiti, più felici e confusi, di una confusione che è apertura, ricchezza, condivisione, e contatto profondo con la bellezza dentro e fuori di noi.